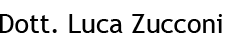Se uno degli obiettivi principali della Comunità Terapeutica Riabilitativa è quello di aumentare l’autonomia della persona, intesa in senso lato come capacità di occuparsi di sé, il percorso riabilitativo non può non occuparsi del reinserimento sociale e lavorativo del paziente.Da un punto di vista clinico, possiamo descrivere il paziente psicotico come caratterizzato dall’avere un Io “destrutturato” (Jung 1916), non in grado di reggere la pervasività dei contenuti inconsci personali ed archetipici. Usando un linguaggio metaforico possiamo immaginare che nella persona psicotica il viaggio dell’Io si è arenato e incastrato tra i frammenti di una personalità scissa e frantumata. In un certo senso è come se la persona psicotica si trovasse in un labirinto che tormenta il pensiero e le emozioni. Un labirinto che fa vivere delle relazioni sociali distorte, fantasie letteralizzate, metafore scambiate per realtà tangibile e paure ad affrontare la realtà esterna e la dimensione del sociale.
Il lavoro, considerata la situazione psichica di una persona psicotica, è uno di quegli strumenti riabilitativi che permette all’Io di riprendere il suo viaggio interrotto. Il lavoro aumentando le competenze concrete, facendo entrare in contatto con gli altri, facilitando lo scambio e le relazioni, di fatto incide positivamente sull’autostima del paziente. Ma più in generale, e tenendo ben in mente un’ottica riabilitativa, possiamo affermare che il reinserimento lavorativo del paziente aiuta l’Io a riprendere quel viaggio, di cui si parlava poco sopra, perché rafforza l’Io stesso del paziente. Proviamo a vederne il perché, facendo una breve digressione.
Ne “Il disagio della civiltà” (1929) Freud va oltre l’idea di lavoro inteso come un impegno coercitivo irriducibilmente in antitesi al piacere, per approdare ad un’idea di lavoro che permette allo stesso tempo di adattarsi alla realtà e di soddisfare alcune esigenze pulsionali. Più precisamente afferma: “Nessuna altra tecnica di condotta della vita lega il singolo così strettamente alla realtà come il concentrarsi sul lavoro…La possibilità di spostare una forte quantità di componenti libidiche, narcisistiche e persino erotiche sul lavoro professionale conferisce al lavoro un valore per nulla inferiore alla sua indispensabilità per il mantenimento e la giustificazione del singolo nella società”. Per l’altro grande padre della psicologia del profondo, Jung, il lavoro può essere considerato una sorta di simbolo che trasforma l’energia psichica, permettendo un “travaso su un analogo dell’oggetto pulsionale” (Jung, 1928, in “Energetica psichica”). Secondo Jung, giusto per fare un esempio, una persona schizofrenica che ha un rapporto simbiotico con la propria madre, iniziando a lavorare la terra sta gradualmente spostando la sua libido dalla madre personale su di un oggetto analogo della madre, la madre-terra.
Secondo entrambi gli Autori, nonostante le divergenze teoriche sul modo di intendere l’energia psichica, il lavoro è quindi in primo luogo un mezzo per adattarsi alla realtà esterna, perciò possiamo dire che rafforza il principio di realtà di un individuo.
In secondo luogo, ma non secondariamente, il lavoro portando l’individuo verso l’esterno agisce di fatto come un ponte che permette il passaggio da un ambiente più ristretto ad uno più grande. Nel caso del paziente psicotico, dalla comunità al contesto sociale più ampio.
Per il paziente grave rientrare con un lavoro nel contesto sociale di appartenenza potrebbe avere, oltre per quanto detto sinora, un valore particolare perché lo potrebbe aiutare nel riacquisire un’identità sociale positiva. Se, come dice Basaglia (1968), “il malato mentale è un malato soprattutto perché è escluso, abbandonato da tutti, perché è una persona senza diritti, nei confronti della quale tutto è possibile”, intuiamo facilmente come il lavoro può divenire quel mezzo di inclusione sociale che avvia il paziente a terminare il suo percorso comunitario.
Se quanto detto fino ad ora è vero, è anche vero che non sempre il reinserimento lavorativo permette alla persona psicotica di ridefinire la propria identità in senso positivo, anzi talvolta il lavoro stesso non fa che rinforzare la tendenza della persona ad identificare se stessa con la sua condizione psicopatologica. Detto in altre parole, una persona schizofrenica, che già di suo è portata ad avvertirsi esclusivamente come malata senza riconoscere altri aspetti di sé, può percepirsi ancor più esclusa, diversa e disabile proprio a causa del lavoro che svolge. Dato che quest’ultima affermazione è chiaramente in antitesi con quanto sostenuto in precedenza, viene spontaneo chiedersi: “In che circostanze il lavoro per il paziente psichiatrico esercita una funzione benefica sulla sua condizione psichica?”.
Per rispondere a tale questione è necessario fare un brevissimo accenno al quadro normativo italiano in materia di reinserimento lavorativo di persone disabili. La legislazione del nostro paese in proposito dispone sostanzialmente di due strumenti in grado di favorire l’occupazione delle persone in condizioni svantaggiate: la legge, 308/1991, che disciplina la cooperazione sociale; e la legge 68/1999 che introduce il concetto di “collocamento mirato”. Sinteticamente ricordiamo che le cooperative sociali del tipo B devono avere almeno un 30% di soci svantaggiati, e che il concetto di collocamento mirato permette una “scelta”, un incontro, tra l’azienda e il lavoratore, superando l’idea che l’impresa deve attingere il lavoratore da una graduatoria, basata sull’anzianità di iscrizione, senza nemmeno conoscere il lavoratore disabile.
Una Comunità Terapeutica Riabilitativa che voglia essere veramente tale, non può limitarsi ad utilizzare il quadro legislativo italiano soltanto per “collocare” il suo paziente, bensì dovrebbe avere il coraggio di prestare attenzione alla qualità del lavoro che va a svolgere il paziente che si sta seguendo, e costruire una rete sociale per il paziente solo con quei soggetti, Cooperative, Associazioni, Centro per l’Impiego, imprese, che vogliono veramente “aprirsi” al contatto con la persona psicotica e offrirle una vera opportunità di mettersi in gioco. Infatti un lavoro in cui il paziente si trova isolato, non a contatto con altre persone, in una mansione che di fatto non richiede nessun impegno o capacità, finisce con il danneggiare la persona psicotica più che con l’aiutarla. Un lavoro del genere rischia di accentuare in misura ancora maggiore la frattura che la persona psicotica ha con il resto del mondo. In poche parole, il paziente inserito in comunità ha bisogno di un lavoro vero e non della benevola carità di qualche cooperativa sociale o peggio ancora di qualche azienda, obbligata a rispettare la legge 68/1999, che di fatto assume il paziente senza realmente però farlo entrare a far parte dell’azienda.
Per far si che il reinserimento lavorativo sia utile e non dannoso, la comunità ha forse solo una strada a sua disposizione: aiutare il paziente a trovare un lavoro riabilitativo. Un lavoro capace cioè di impegnare la persona a livello emotivo e cognitivo, in qualcosa che senta intimamente suo, e non un qualcosa di puramente assistenziale. Solo così il lavoro può esplicare i suoi effetti benefici a livello psichico. Certamente questa è la strada più difficile, ma la comunità e il paziente psichiatrico spesso non hanno alternativa allo scegliere, parafrasando Robert Frost, “ la strada meno battuta”.